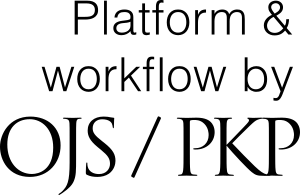Call for Papers: Allieve/allievi-Maestre/maestri
A cura di Federica Muzzarelli, Claudio Zambianchi e Giorgio Zanchetti.
Scarica questa call for paper (PDF)
Per il prossimo numero di «piano b» la redazione ha pensato che un terreno fertile di indagine possa essere quello del rapporto fra maestre/i e allieve/i tra gli anni Settanta e Ottanta in Italia. Nei Settanta, per la prima volta nel nostro Paese, nascono cattedre universitarie specificamente dedicate all’arte contemporanea; molti storici dell’arte del Novecento continuano inoltre a insegnare nelle Accademie di Belle Arti. Le loro allieve e i loro allievi possono appartenere quindi al mondo della creazione o al mondo della critica e storia dell’arte. L’auspicio di «piano b» è quello di raccogliere una decina di contributi che prendano in esame gli esiti della relazione fra coloro che hanno avuto una responsabilità didattica, anche non rigorosamente strutturata (da professori universitari o di Accademia), e le più giovani generazioni. Figure come, per esempio, Giulio Carlo Argan, Nello Ponente, Filiberto Menna, Enrico Crispolti, Luciano Caramel, Francesco Arcangeli, Anna Maria Brizio, Paolo Fossati, Alberto Boatto, Renato Barilli, Maurizio Calvesi, Mirella Bandini, Corrado Levi, Marisa Volpi, Tommaso Trini, Rossana Bossaglia o anche artisti dediti, parallelamente al lavoro visivo, a un’attività critico-teorica di spessore (ad esempio Luciano Fabro a Milano o Toti Scialoja a Roma) hanno esercitato un notevole influsso sulle loro allieve e sui loro allievi. L’influenza delle maestre e dei maestri è temperato dal fatto che, proprio nella fase Settanta-Ottanta, è più difficile che in precedenza trovare casi di discipulato “dogmatico”: l’orizzonte delle nuove generazioni si è infatti allargato e i riferimenti critici si sono estesi al panorama internazionale. In molti casi, tuttavia, resta riconoscibile l’impronta iniziale del/la didatta. Esistono anche alcuni casi interessanti di maestri o maestre che seguono con interesse il lavoro di colleghe/i più giovani, senza che queste ultime o questi ultimi siano stati ospiti assidui/e nelle loro classi universitarie o accademiche. Gli interventi, visti i decenni proposti, potranno considerare anche altre figure di viventi, preferibilmente fra le allieve e gli allievi. Di pari interesse sono le collaborazioni tra maestre/i e allieve/i per progetti editoriali ed espositivi. Vorremo, tuttavia, evitare contributi di natura memorialistica o personale, comprese le interviste.
Una sezione speciale del numero sarà dedicato ad alcuni interventi su Francesca Alinovi, esito della giornata di studi tenutasi a Bologna nella primavera scorsa.
Come sottoporre un contributo
La rivista accetta solo contributi completi (30.000/40.000 battute, note e spazi inclusi) inviati secondo le modalità sottoindicate. Le curatrici e/o i curatori di ogni numero valutano i contributi e selezionano quelli che andranno alla fase di referaggio doppio cieco. La redazione avviserà le autrici e gli autori dell’esito della valutazione.
Le autrici e gli autori devono presentare gli articoli tramite la piattaforma della rivista, usando il processo di invio di una proposta in 5 passaggi.
Il file dovrà contenere il testo della proposta senza che il nome dell’autrice o dell’autore appaia sotto al titolo, nelle note o nei riferimenti bibliografici (dove andrà sostituito con ***). Il file dovrà essere obbligatoriamente reso anonimo. Il nome dell'autrice o dell'autore non dovrà essere esplicitato in alcun modo. Andranno inoltre esclusi riferimenti che permettano di risalire all'autore stesso, altrimenti la proposta non sarà presa in considerazione. Inoltre le proprietà del file dovranno essere prive di nomi o altri dettagli personali, mediante le funzioni di anonimizzazione fornite dai vari programmi di scrittura (vedere in merito le istruzioni su come Assicurare una revisione a doppio cieco).
Il file anonimo del contributo dovrà essere caricato allo step 2 del processo. Il testo dovrà aderire alle linee guida indicate per la formattazione.
I metadati della proposta saranno inseriti allo step 3 del processo e dovranno includere le seguenti informazioni:
- Per ciascun’autrice e ciascun autore: nome e cognome, e-mail, identificativo ORCiD (se disponibile), affiliazione istituzionale, paese, e una biografia sintetica (massimo 1000 battute, spazi inclusi);
- Titolo;
- Abstract (massimo 1500 battute, spazi inclusi);
- Cinque parole chiave separate da punto e virgola;
I contributi potranno essere scritti in lingua italiana, inglese e francese. Proponendo un contributo in lingua italiana o francese, titolo e abstract dovranno essere forniti anche in inglese, tramite la funzione “Lingua dei moduli” presente sulla piattaforma.
Non saranno prese in considerazione proposte inviate secondo altre modalità.
Tempistiche
Le proposte dovranno pervenire entro il 15 gennaio 2026 (scadenza prorogata). Ogni contributo sarà sottoposto a procedura di double-blind peer review. Se i giudizi delle/dei due referee saranno in contrasto, i direttori decideranno (in dialogo con le curatrici e i curatori) se assumere la decisione di pubblicazione o di invio a una/un terza/o referee. La redazione contatterà le autrici e gli autori per comunicare l’esito della valutazione.
L’uscita del vol. 10 n. 2 è prevista per la primavera 2026.