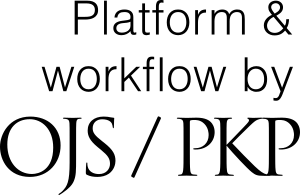Call for Papers: Ascoltare l’ambiente. Risonanze dell’arte nel paesaggio italiano
A cura di Lara Conte e Pasquale Fameli
Scarica questa Call for Papers (PDF)
Con le pratiche delle neoavanguardie, emerse negli anni Sessanta, l’opera d’arte non abbandona solo i suoi più convenzionali supporti ma anche i luoghi a essa deputati per svilupparsi direttamente nell’ambiente, naturale o urbano. In Italia mostre collettive come Parole sui muri (Fiumalbo, 1967), Un paese + l’avanguardia artistica (Anfo, 1968), Arte povera più azioni povere (Amalfi, 1968), Campo urbano (Como, 1969), e altre, hanno avviato nuove strategie espositive, collocando l’esperienza artistica in una prospettiva orizzontale, a stretto contatto con la natura, con lo spazio urbano e con le comunità. In questo clima di sperimentazione totale, sono emerse alcune delle prime ricerche volte all’impiego del suono, declinato a seconda dei casi come presenza plastica o fattore di relazione. Si tratta di interventi spesso effimeri, legati alla temporaneità della singola mostra, ai processi mutevoli della natura, alla precarietà, residualità e biodegradabilità dei materiali impiegati o all’esigenza di evidenziare, attivare e ridefinire le funzioni di un dato luogo. La mostra Sonorità prospettiche, tenutasi a Rimini nel 1982, ha costituito la prima occasione italiana per una ricognizione delle ricerche artistiche nazionali e internazionali incentrate sul rapporto tra suono e ambiente, con interventi pionieristici e più recenti di John Cage, Alvin Curran, Bill Fontana, Christina Kubisch, Alvin Lucier, Max Neuhaus o, tra gli italiani, Claudio Ambrosini, Dal Bosco-Varesco, Davide Mosconi, Maurizio Nannucci, Roberto Taroni e molti altri.
Negli ultimi decenni l’interesse delle artiste e degli artisti per il suono come modalità di intervento ambientale è cresciuto esponenzialmente, dando vita a esperienze disomogenee e discontinue che oggi è necessario comprendere e studiare, anche in virtù della loro aderenza a tematiche cruciali della contemporaneità – dai cambiamenti climatici ai mutamenti identitari del paesaggio antropico, dall’opposizione tra centro e periferia alle problematiche della marginalità e delle minoranze culturali. Anche in più recenti studi sulla scultura contemporanea si è delineata una prima prospettiva di ricognizione sul rapporto tra processo plastico e suono, prendendo in considerazione esperienze che non sono state ancora analizzate nella loro complessità di ricezione e relazione. D’altra parte, la messe di esperienze che nasce dall’inte-razione tra pratica artistica e suono è spesso ricondotta alla categoria tanto abusata quanto problematica di Sound Art, ma di fatto questa etichetta rischia di semplificare un dibattito complesso che attraversa questioni nodali: la residualità dei siti di realizzazione, le proprietà acustiche dei materiali, l’apporto delle tecnologie, per menzionarne solo alcune.
Da queste considerazioni muove la presente CFP di “piano b”, con l’obiettivo di raccogliere approfondimenti e riflessioni sul rapporto tra suono e paesaggio nelle ricerche artistiche italiane dagli anni Sessanta a oggi, con particolare attenzione agli interventi processuali, installativi e partecipativi realizzati in luoghi decentrati, periferici e marginali della Penisola. Nell’ambito del PRIN 2022 PNRR Art Sound Environment: Towards a New Ecology of Landscape e a partire anche dai dati emersi nella mappatura consultabile al sito https://ase.uniroma3.it/ si propone pertanto la stesura di contributi scientifici attorno ai seguenti temi:
- analisi delle mostre e degli interventi installativi e performativi sonori realizzati in Italia, con particolare attenzione alla progettualità realizzata nei centri minori e in aree geografiche decentrate e marginali;
- problemi conservativi e documentativi connessi alle pratiche artistiche sonore realizzate nello spazio urbano o nel contesto naturale;
- relazioni tra scultura, natura e suono;
- pratiche di field-recording e di rilocazione del suono;
- azione artistica come pratica di ecologia dell’ascolto;
- interventi artistici sonori incentrati sull’identità collettiva e territoriale;
- relazioni tra arte, suono e ambiente connesse a questioni sociologiche;
- estetica relazionale e ricerca sonora.
Come sottoporre un contributo
La rivista accetta solo contributi completi (30.000/40.000 battute, note e spazi inclusi) inviati secondo le modalità sottoindicate. Le curatrici e/o i curatori di ogni numero valutano i contributi e selezionano quelli che andranno alla fase di referaggio doppio cieco. La redazione avviserà le autrici e gli autori dell’esito della valutazione.
Le autrici e gli autori devono presentare gli articoli tramite la piattaforma della rivista, usando il processo di invio di una proposta in 5 passaggi.
Il file dovrà contenere il testo della proposta senza che il nome dell’autrice o dell’autore appaia sotto al titolo, nelle note o nei riferimenti bibliografici (dove andrà sostituito con ***). Il file dovrà essere obbligatoriamente reso anonimo. Il nome dell'autrice o dell'autore non dovrà essere esplicitato in alcun modo. Andranno inoltre esclusi riferimenti che permettano di risalire all'autore stesso, altrimenti la proposta non sarà presa in considerazione. Inoltre le proprietà del file dovranno essere prive di nomi o altri dettagli personali, mediante le funzioni di anonimizzazione fornite dai vari programmi di scrittura (vedere in merito le istruzioni su come Assicurare una revisione a doppio cieco).
Il file anonimo del contributo dovrà essere caricato allo step 2 del processo. Il testo dovrà aderire alle linee guida indicate per la formattazione.
I metadati della proposta saranno inseriti allo step 3 del processo e dovranno includere le seguenti informazioni:
1. Per ciascun’autrice e ciascun autore: nome e cognome, e-mail, identificativo ORCiD (se disponibile), affiliazione istituzionale, paese, e una biografia sintetica (massimo 1000 battute, spazi inclusi);
2. Titolo;
3. Abstract (massimo 1500 battute, spazi inclusi);
4. Cinque parole chiave separate da punto e virgola;
I contributi potranno essere scritti in lingua italiana, inglese e francese. Proponendo un contributo in lingua italiana o francese, titolo e abstract dovranno essere forniti anche in inglese, tramite la funzione “Lingua dei moduli” presente sulla piattaforma.
Non saranno prese in considerazione proposte inviate secondo altre modalità.
Tempistiche
Le proposte dovranno pervenire entro il 6 marzo 2026. Ogni contributo sarà sottoposto a procedura di double-blind peer review. Se i giudizi delle/dei due referee saranno in contrasto, i direttori decideranno (in dialogo con le curatrici e i curatori) se assumere la decisione di pubblicazione o di invio a una/un terza/o referee. La redazione contatterà le autrici e gli autori per comunicare l’esito della valutazione.
L’uscita del vol. 13 n. 1 è prevista per giugno/luglio 2026.